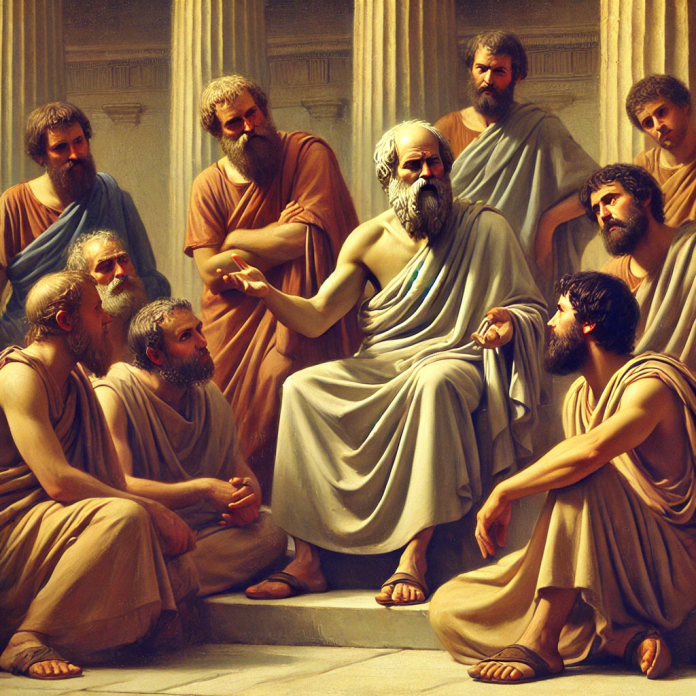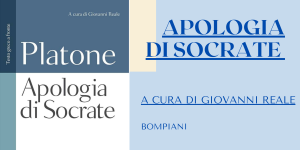Il Processo di Socrate
Nel maggio del 399 a.C., 500 giudici si radunarono nello spiazzo del tribunale cittadino per il processo a Socrate. Tra il pubblico era presente anche un giovane Platone. I giudici erano estratti a sorte da una lista di 6000 persone redatta all’inizio dell’anno. Ad ogni giudice venivano forniti tre ovuli per esprimere il voto: uno per l’innocenza, uno per la colpevolezza e uno per decidere la pena. L’accusa venne presentata da tre cittadini: Meleto, Anito e Licone. I capi d’accusa contro Socrate erano tre:
- Non venerare gli dèi tradizionali;
- Introdurre nuove divinità;
- Corrompere i giovani.
Socrate, pur essendo un uomo indigente e dedito alla sua missione educativa, frequentava le case degli uomini più influenti, tra cui Crizia. La sua figura, tuttavia, non era elitaria, bensì legata a un gruppo di giovani che, dopo di lui, diedero vita ai dialoghi socratici, tra cui Platone e Senofonte.
Autenticità e Interpretazioni dell’Apologia
Oggi non si dubita dell’autenticità dell’Apologia di Socrate, redatta entro due o tre anni dalla sua morte, avvenuta nel 399 a.C. Tuttavia, la questione che divide gli studiosi riguarda la storicità del testo. L’Apologia è un fedele resoconto del discorso di Socrate durante il processo, oppure è una difesa costruita da Platone per scagionare il maestro?
Vi sono due interpretazioni principali:
- L’Apologia rappresenta il pensiero del Socrate storico;
- L’Apologia è un’opera che riflette più le idee di Platone che quelle di Socrate.
Oggi prevale una terza interpretazione: il discorso socratico esposto da Platone non è né una pura invenzione né una trascrizione letterale, ma una sua rielaborazione basata su eventi reali.
I personaggi
Nell’Apologia di Socrate di Platone, Meleto, Anito e Licone sono i tre principali accusatori di Socrate. Ognuno di loro rappresenta un diverso gruppo sociale e politico che si oppone al filosofo.
-
Meleto: È il principale accusatore formale di Socrate. Viene descritto come un giovane poeta, privo di grande autorevolezza, ma strumento nelle mani di altri. Nell’opera appare come colui che ha scritto l’atto d’accusa contro Socrate, sostenendo che egli corrompe i giovani e non crede negli dèi della città. Socrate lo ridicolizza durante il processo, mettendo in luce le sue contraddizioni e la scarsa preparazione filosofica.
-
Anito: È un esponente della classe politica e degli artigiani ricchi. Rappresenta il partito democratico ed è particolarmente ostile a Socrate perché lo considera un pericolo per l’educazione tradizionale e per l’ordine della città. Anito teme che le idee socratiche possano minare l’autorità dei governanti e favorire la rovina di Atene. Il suo coinvolgimento nell’accusa dimostra il conflitto tra la filosofia socratica e la politica ateniese.
-
Licone: È meno conosciuto rispetto agli altri due accusatori. Viene indicato da Platone come un oratore, quindi un rappresentante dei sofisti e del mondo della retorica. La sua opposizione a Socrate potrebbe derivare dalla critica che il filosofo muoveva nei confronti dei sofisti, accusandoli di insegnare la persuasione senza il vero sapere.
Questi tre personaggi incarnano, quindi, le forze che si oppongono a Socrate: la tradizione religiosa (Meleto), la politica democratica (Anito) e la retorica sofistica (Licone). Essi rappresentano il conservatorismo e la resistenza della società ateniese alle innovazioni filosofiche proposte da Socrate.
Il Conflitto tra Filosofia e Politica
L’Apologia di Socrate mette in scena il conflitto tra filosofia e politica, un tema centrale nel pensiero platonico. Questo contrasto porterà Platone a immaginare, nella Repubblica, una città governata dai filosofi.
Socrate è protagonista di quasi tutti i dialoghi platonici, ma l’Apologia è unica nel suo genere: è l’unico testo in cui il nome di Socrate compare già nel titolo.
Struttura dell’Apologia
L’opera non è solo un documento storico, ma anche un’opera letteraria e filosofica. Platone seleziona attentamente gli eventi da raccontare, concentrandosi solo sui discorsi di Socrate e omettendo le parole dell’accusa e le votazioni.
L’Apologia si divide in tre parti, corrispondenti a tre distinti discorsi socratici:
- Primo discorso: La difesa di Socrate;
- Secondo discorso: La controproposta sulla pena;
- Terzo discorso: Il commiato di Socrate ai cittadini ateniesi.
L’ultima parte, il commiato, è probabilmente un’invenzione letteraria di Platone, in cui Socrate esorta i suoi concittadini a continuare a filosofare nonostante la sua condanna.
Primo discorso: la difesa di Socrate
Socrate esordisce contrapponendo retorica e sincerità: la sua difesa si basa esclusivamente sulla verità. Egli respinge l’accusa di essere un sofista e di ricevere denaro per il suo insegnamento.
Racconta poi l’episodio dell’Oracolo di Delfi, che lo aveva proclamato il più sapiente tra gli uomini. La sua sapienza non consiste nel sapere tutto, ma nel riconoscere la propria ignoranza. Il suo tentativo di confutare i falsi sapienti gli ha procurato l’inimicizia di molti, che ora si vendicano attraverso l’accusa formale.
Nel corso di un interrogatorio con Meleto, Socrate dimostra l’inconsistenza delle accuse. La presunta corruzione dei giovani non ha fondamento: se fosse vero, chi si occupa della loro educazione? Inoltre, l’accusa di introdurre nuove divinità è contraddittoria, poiché Meleto lo accusa contemporaneamente di ateismo e di credere in esseri divini.
Socrate considera la sua missione filosofica un compito affidatogli dagli dèi e afferma di essere pronto a morire pur di restare fedele alla verità. Rinuncia a fare leva sulla compassione dei giudici, mantenendo una posizione di dignità e orgoglio.
Secondo discorso: la proposta di pena
Dopo la sentenza di colpevolezza, Socrate afferma che, invece di una punizione, meriterebbe una ricompensa per i benefici apportati alla città. Esclude sia l’esilio sia la carcerazione, in quanto non potrebbe continuare la sua missione educativa. Propone quindi una multa, che potrebbe essere pagata con l’aiuto dei suoi amici, tra cui Platone.
Terzo discorso: il commiato di Socrate
Dopo la condanna a morte, Socrate si rivolge sia ai suoi accusatori sia ai suoi sostenitori. Ai primi dice che la sua esecuzione non fermerà la ricerca filosofica, mentre ai secondi insegna che la morte non è necessariamente un male, ma un passaggio verso una condizione migliore.
Socrate conclude il suo discorso con una riflessione sulla morte: se essa è un sonno eterno, allora è priva di sofferenza; se invece porta all’immortalità dell’anima, sarà un’occasione per continuare a cercare la verità.
Le ragioni della condanna
Socrate non è stato condannato solo per empietà, ma anche per motivi politici. Le accuse ufficiali mascheravano il timore che la sua attività filosofica minasse l’ordine pubblico.
Il processo si svolse in un momento storico delicato, in cui Atene era reduce da conflitti politici tra oligarchici e democratici. Socrate era stato maestro di figure controverse come Crizia e Alcibiade, suscitando sospetti tra i democratici.
Inoltre, la sua continua critica ai potenti e il suo metodo maieutico mettevano in discussione il sapere tradizionale, facendo di lui un elemento sovversivo. La città, dunque, lo condannò non solo come empio, ma come pericoloso per l’ordine costituito.
L’Apologia di Socrate non è solo una difesa processuale, ma un manifesto filosofico sulla libertà di pensiero. Socrate accetta la morte con serenità, rifiutando compromessi e restando fedele alla sua missione.
Attraverso le sue parole, Platone trasforma il processo di Socrate in un evento simbolico, ponendo le basi per la filosofia occidentale e la riflessione sulla giustizia, la politica e la ricerca della verità.
Altre opere di Platone commentate su Bassaparola:
- Apologia di Socrate – Socrate si difende dalle accuse di corruzione dei giovani e di empietà, sostenendo la propria innocenza e dichiarando di non temere la morte.
- Simposio – Una serie di discorsi sull’amore, culminanti nella concezione dell’amore come desiderio di conoscenza e bellezza assoluta.
- Gorgia – Critica la retorica sofistica e discute la relazione tra potere e giustizia, sostenendo la superiorità della vita giusta.
- Eutifrone – Socrate chiede cosa sia la pietà e, spoiler, non ottiene una risposta. Un capolavoro di confusione socratica vestita da logica implacabile.
- Critone – Socrate, in prigione, discute con Critone sull’importanza di rispettare le leggi, rifiutando la proposta di fuga e accettando la condanna a morte.
- La Repubblica – Esamina la natura della giustizia e descrive lo Stato ideale, introducendo la teoria delle idee e il mito della caverna.
- Fedone – Nell’ultimo giorno di vita di Socrate, si affronta il tema dell’immortalità dell’anima e della filosofia come preparazione alla morte.
- Sofista – Analizza la figura del sofista e la distinzione tra essere e non essere, approfondendo la natura dell’errore e dell’apparenza.
- Protagora – Sofisti contro filosofi: Platone racconta un dibattito epico sulla virtù. La virtù si può insegnare?
- Timeo – Offre una cosmologia in cui il Demiurgo ordina il caos secondo modelli eterni, creando un cosmo armonioso.
- Lachete – Socrate chiede a due generali cosa sia il coraggio, ma finisce per confonderli. Un dialogo breve che dimostra che Platone sapeva rendere anche i guerrieri filosofi.
- Crizia – Racconta la storia di Atlantide e della sua guerra contro l’antica Atene, presentando una civiltà avanzata poi scomparsa.
- Filebo – Esamina il confronto tra piacere e intelligenza nella ricerca della vita felice, sostenendo la superiorità dell’intelletto.
- Menone – Indaga se la virtù possa essere insegnata, introducendo la teoria della reminiscenza e l’idea che la conoscenza sia innata.
- Parmenide – Idee contro Cose Sensibili, il difficile rapporto tra Uno e Molti
- Politico – Discute la natura del vero politico e il ruolo della scienza politica nel governare, distinguendo tra diverse forme di governo.
- Parmenide – Idee contro Cose Sensibili: il difficile rapporto tra Uno e Molti
- Teeteto – Esplora la natura della conoscenza, esaminando definizioni come “conoscenza è percezione” e “conoscenza è opinione vera”.
- Leggi: Ultimo e più lungo dialogo, propone un sistema legislativo per una città ideale, enfatizzando l’importanza delle leggi nella vita sociale.
- Oppure visita la Guida completa alle opere di Platone per perderti con stile tra le idee immortali.