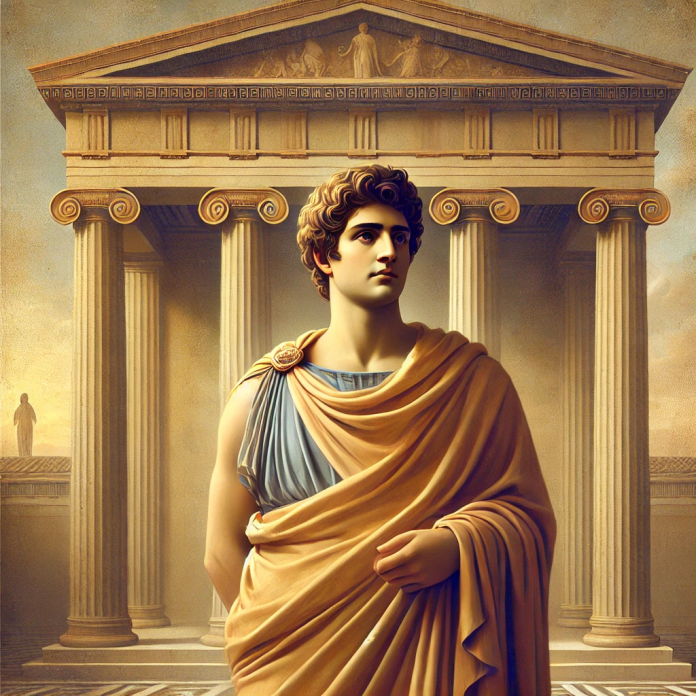Scopri il “Menone” di Platone: un dialogo sulla natura della virtù, l’importanza della conoscenza, la teoria dell’anamnesi e il ruolo dell’educazione nella formazione politica. Una guida essenziale al pensiero platonico maturo.
Quando è stato scritto?
Il dialogo chiude la fase degli scritti giovanili e della prima maturità, aprendo la serie dei capolavori dell’età matura; alcuni lo considerano addirittura una preparazione della Repubblica. Sicuramente fu composto dopo il 387 a.C., ossia dopo il ritorno dall’avventuroso viaggio in Italia, poiché incorpora le nuove dimensioni acquisite dal pensiero platonico in quell’esperienza. In particolare, evidenzia l’ampio impiego della matematica e del suo metodo, integrati al dialogo socratico, nonché le dottrine orfico-pitagoriche della metempsicosi e l’avvio del grande progetto di una scuola che rievoca quanto già sperimentato in Italia dai pitagorici.
I personaggi:
La scelta di Menone come personaggio, giovane di stirpe principesca, bello, con un interesse per la filosofia e desideroso di cose grandi, apporta significato all’opera educativa della scuola di Platone, che si rivolge proprio a soggetti come lui. Menone apparteneva a una famiglia nobile e ricca della Tessaglia e, secondo alcune fonti, fu uno dei condottieri greci che parteciparono alla spedizione di Ciro il Giovane contro il fratello Artaserse. Dopo la sconfitta di Ciro, Menone cadde prigioniero e venne ucciso. Senofonte lo descrive come avido di ricchezze e potere, disposto a ricorrere a menzogne e spergiuri. Platone, tuttavia, vede in lui soprattutto le qualità che avrebbero potuto farne un politico.
In questo contesto, risulta simbolico anche il personaggio di Anito, uno degli uomini politici più influenti del tempo. Anito, rappresentante della vecchia Atene tradizionalista e conservatrice in fatto di educazione politica, non viene trattato da Platone come ci si potrebbe aspettare, dato che fu responsabile del processo e della condanna di Socrate. Platone non vuole sottoporre a processo gli accusatori di Socrate, ma intende piuttosto rappresentare una certa mentalità di quella categoria di persone per cui il problema della virtù politica non si pone nemmeno.
Qual è tema del dialogo?
Il tema del dialogo è già enunciato nella domanda d’apertura. Menone chiede a Socrate in che modo si produca la virtù, ossia se essa possa essere acquisita mediante l’insegnamento, attraverso l’esercizio pratico, se sia innata o derivi da qualche altra causa. Di fronte a tale quesito, Socrate ammette di non saper rispondere e, anzi, confessa di non conoscere nemmeno l’essenza della virtù, non avendo mai incontrato nessuno che la comprendesse veramente. La soluzione del problema, pertanto, richiede prima di tutto una definizione dell’essenza della virtù.
Prima definizione di virtù:
Menone, stupito dall’ignoranza di Socrate, crede, seguendo l’insegnamento di Gorgia, di poter facilmente definire la virtù. Egli afferma che la virtù dell’uomo consista nell’abilità politica e quella della donna in quella domestica; analogamente, si dovrebbe dire per il fanciullo, la fanciulla, l’anziano, il libero e lo schiavo, ciascuno secondo una peculiarità diversa. Tuttavia, alla richiesta di enunciare l’essenza della virtù, Menone non risponde in maniera univoca, limitandosi ad elencare molteplici casi. Ciò non equivale a definire la virtù, poiché deve esistere una forma o essenza comune che renda tutte le virtù omogenee, distinguendo ciò che è virtuoso da ciò che non lo è. In altre parole, amministrare con giustizia e saggezza significa che, per essere virtuosi, uomo e donna debbano possedere gli stessi caratteri, così come devono esserlo anziani, fanciulli e schiavi.
Seconda definizione di virtù:
Menone propone allora una seconda definizione, sostenendo che la virtù consista nell’essere capace di comandare gli uomini. Pur rappresentando un miglioramento rispetto alla prima proposta, questa definizione risulta insufficiente perché non è abbastanza comprensiva: non basta saper comandare in generale, bensì è necessario comandare con giustizia. Menone sembra ritenere tale definizione soddisfacente, affermando che la giustizia, essendo una virtù, dovrebbe essere la base da cui scaturiscono anche le altre virtù – quali la fortezza, la temperanza, la magnanimità e simili. Tuttavia, da qui riemerge il problema della molteplicità delle virtù.
Per chiarire il concetto, Socrate fornisce esempi concreti. Per definire il colore, adotta un approccio differente, ispirandosi alla teoria empedoclea condivisa da Gorgia e quindi da Menone: il colore è l’emanazione delle figure, proporzionata alla vista e percettibile. Pur riconoscendo l’effetto notevole di questa definizione, Socrate la giudica comunque inadeguata; tuttavia, la enuncia per trasmettere a Menone l’idea che intende esprimere.
Terza definizione di virtù
La terza definizione di virtù proposta da Menone consiste nel desiderare le cose belle e nel saperle procurare. Socrate osserva che, poiché il bello coincide con il buono, questa definizione si riduce al fatto che la virtù consiste nel desiderare il bene e nel saperlo procurare. Tuttavia, poiché tutti desiderano ciò che è bene – anche se talvolta per ignoranza, ritenendo il male comunque un bene – nel semplice desiderare e cercare di procurarsi il bene nessuno risulta migliore di un altro.
Della definizione di Menone rimane rilevante solo la seconda parte: la virtù consiste nel saper procurarsi le cose buone. Socrate sottolinea però che non ogni modo di procurarsi ciò che è buono è virtuoso, ma solo quello giusto. Menone accetta questa precisazione, riformulando la definizione nel seguente modo: la virtù consiste nel procurarsi le cose buone secondo giustizia.
Anche così la definizione non regge, perché essa definisce la virtù ricorrendo alla giustizia, che rappresenta solo una parte della virtù, e segmenta la virtù in diverse componenti senza riuscire a individuare l’unità che la abbraccia in toto. L’unico risultato positivo è che Menone ammette di non saper definire l’essenza della virtù, offrendo così uno scacco non solo a Menone stesso, ma anche a Gorgia.
La teoria della anamnesi
Menone obietta a Socrate che, se davvero non si conosce la natura della virtù, ogni ricerca risulterebbe vana, poiché, anche se la si trovasse, senza una conoscenza precisa non si potrebbe riconoscere se essa corrisponda a ciò che si cercava.
Questa obiezione viene stroncata dalla teoria dell’anamnesi, secondo la quale l’uomo riscopre la verità ricordandola, facendola emergere dalla propria anima. Tale teoria, che affonda le sue radici nella dottrina orfico-pitagorica della metempsicosi, si fonda sull’idea che l’anima, immortale e dotata di una conoscenza pregressa di tutto ciò che esiste sia nell’Ade che sulla terra, debba semplicemente richiamare alla mente ciò che ha sempre saputo. In questo senso, apprendere non è altro che ricordare.
A supporto di questa dottrina, Socrate propone un esperimento maieutico: interroga un giovane schiavo di Menone, facendogli risolvere un problema di geometria. Sebbene il ragazzo non avesse mai studiato questa disciplina, sotto la guida di Socrate egli ritrova in sé alcune nozioni, giungendo così alla soluzione corretta del problema. Questo dimostra che il sapere risiede nell’anima e che l’apprendimento consiste nel far emergere quella conoscenza preesistente.
Platone, attraverso le parole di Socrate al termine dell’esperimento, afferma che la verità degli oggetti esterni risiede nell’anima nostra. L’anima, che possiede in sé la verità da sempre, è immortale quanto essa stessa. Di conseguenza, non esiste verità che l’uomo non possa conoscere.
Da qui scaturisce la questione se la virtù, per essere insegnabile, debba essere intesa come una proprietà dell’anima – o, meglio, come una vera scienza, poiché solo ciò che è scientifico è trasmissibile. Essendo la virtù un bene utile e giovevole, i virtuosi dovrebbero raggiungerla non per una predisposizione naturale, ma attraverso l’insegnamento e l’educazione. Tuttavia, sorge il dubbio: mentre per molte discipline esistono insegnanti e scuole, sembrano mancare i veri maestri di virtù.
L’intervento di Anito
Socrate chiede ad Anito se conosca dei maestri di virtù, e in caso affermativo di indicare quali siano. Della virtù nessuno si professa maestro, ad eccezione dei sofisti, ma al solo udire il loro nome Anito esplode: afferma di non averli mai incontrati e di sapere benissimo che essi sono la rovina di chi li frequenta. Non solo non migliorano i loro discepoli, ma li corrompono, dimostrando di essere astuti profittatori.
A questo punto, Socrate osserva che, al di là dei sofisti, gli ateniesi onesti hanno appreso la virtù dai propri padri e antenati e la trasmetterebbero ai figli. Tuttavia, non ogni ateniese onesto è in grado di rendere altri onesti, nemmeno i migliori. Infatti, Socrate cita quattro illustri esempi – Temistocle, Aristide, Pericle e Tucidide – i quali, pur essendo maestri di virtù, non seppero rendere virtuosi neppure i propri figli.
Anito ritiene queste affermazioni una diffamazione dei grandi ateniesi e se ne risente: ammonisce Socrate e mormora una cupa minaccia, che sembra alludere al processo contro di lui. Anito, come già ricordato, fu uno dei maggiori responsabili della condanna a morte di Socrate.
Come nasce la virtù negli uomini?
Socrate chiarisce che, oltre alla scienza, vi è anche la “retta opinione”: essa può guidare, non solo chi conosce già la strada, ma anche chi, pur non avendola mai percorsa, sa intuire perfettamente la direzione giusta. La differenza fondamentale tra scienza e “retta opinione” è che la prima è stabile, mentre la seconda è instabile. I grandi politici ateniesi citati, così come altri, hanno governato la città non grazie alla scienza, ma grazie alla “retta opinione”; ma non sono riusciti a formare altri uomini simili a loro. L’opinione vera è infatti un intuito inconsapevole, non un sapere riflesso e consapevole, e pertanto questi uomini politici si collocano sullo stesso piano di indovini, profeti e poeti ispirati: sono capaci di cogliere il giusto, ma senza una riflessa consapevolezza.
Secondo Socrate, tali politici hanno ottenuto la virtù non per natura, né per insegnamento, ma come dono divino. Di conseguenza, il problema iniziale—come si produce la virtù—si risolve così: la virtù è data solo per grazia divina, a meno che non esista un uomo capace di rendere politici anche gli altri; se tale uomo esistesse, sarebbe come Tiresia, emerso dalle ombre dei morti. È ormai chiaro che Platone si considerava quel politico consapevole, ossia colui che raggiunge la virtù non per retto opinione, ma per scienza.
Il messaggio di Menone, in sintesi, rivolto ai giovani: se possedete le doti di Menone, lasciatevi convincere e iniziate il vostro percorso nell’Accademia. Non comportatevi come lui, che, pur avendo il potenziale per compiere grandi cose, è fallito e finito in modo misero perché privo della conoscenza che lo avrebbe potuto rendere un buon politico.
Altre opere di Platone commentate su Bassaparola:
- Apologia di Socrate – Socrate si difende dalle accuse di corruzione dei giovani e di empietà, sostenendo la propria innocenza e dichiarando di non temere la morte.
- Simposio – Una serie di discorsi sull’amore, culminanti nella concezione dell’amore come desiderio di conoscenza e bellezza assoluta.
- Gorgia – Critica la retorica sofistica e discute la relazione tra potere e giustizia, sostenendo la superiorità della vita giusta.
- Eutifrone – Socrate chiede cosa sia la pietà e, spoiler, non ottiene una risposta. Un capolavoro di confusione socratica vestita da logica implacabile.
- Critone – Socrate, in prigione, discute con Critone sull’importanza di rispettare le leggi, rifiutando la proposta di fuga e accettando la condanna a morte.
- La Repubblica – Esamina la natura della giustizia e descrive lo Stato ideale, introducendo la teoria delle idee e il mito della caverna.
- Fedone – Nell’ultimo giorno di vita di Socrate, si affronta il tema dell’immortalità dell’anima e della filosofia come preparazione alla morte.
- Sofista – Analizza la figura del sofista e la distinzione tra essere e non essere, approfondendo la natura dell’errore e dell’apparenza.
- Protagora – Sofisti contro filosofi: Platone racconta un dibattito epico sulla virtù. La virtù si può insegnare?
- Timeo – Offre una cosmologia in cui il Demiurgo ordina il caos secondo modelli eterni, creando un cosmo armonioso.
- Lachete – Socrate chiede a due generali cosa sia il coraggio, ma finisce per confonderli. Un dialogo breve che dimostra che Platone sapeva rendere anche i guerrieri filosofi.
- Crizia – Racconta la storia di Atlantide e della sua guerra contro l’antica Atene, presentando una civiltà avanzata poi scomparsa.
- Filebo – Esamina il confronto tra piacere e intelligenza nella ricerca della vita felice, sostenendo la superiorità dell’intelletto.
- Menone – Indaga se la virtù possa essere insegnata, introducendo la teoria della reminiscenza e l’idea che la conoscenza sia innata.
- Politico – Discute la natura del vero politico e il ruolo della scienza politica nel governare, distinguendo tra diverse forme di governo.
- Parmenide – Idee contro Cose Sensibili: il difficile rapporto tra Uno e Molti
- Teeteto – Esplora la natura della conoscenza, esaminando definizioni come “conoscenza è percezione” e “conoscenza è opinione vera”.
- Leggi: Ultimo e più lungo dialogo, propone un sistema legislativo per una città ideale, enfatizzando l’importanza delle leggi nella vita sociale.
- Oppure visita la Guida completa alle opere di Platone per perderti con stile tra le idee immortali.