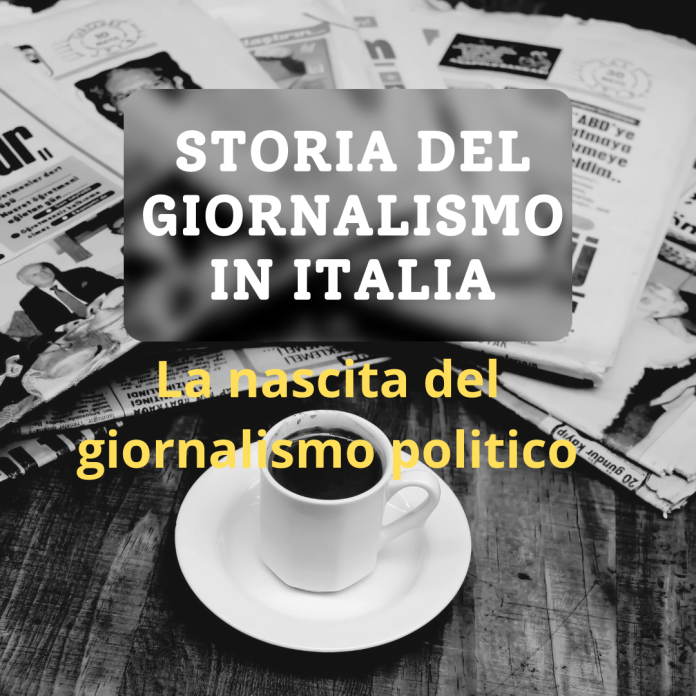Libertà di stampa e Rivoluzione: l’evoluzione del giornalismo italiano tra 1789 e 1814, tra gazzette politiche, censura napoleonica e nascita del giornalismo moderno.
Libertà di stampa e rivoluzione: una svolta epocale
La Rivoluzione Francese rappresenta un momento di svolta fondamentale per la stampa e il giornalismo. L’articolo undicesimo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 26 agosto 1789 proclama la libertà di comunicazione del pensiero e delle opinioni come uno dei diritti più preziosi. Questo principio sarà presto recepito anche negli Stati Uniti, dove nel 1791 viene sancito dal Primo Emendamento della Costituzione americana.
Con l’affermarsi di questi principi nasce il giornalismo politico moderno, capace di formare un’opinione pubblica consapevole. In Italia, le notizie provenienti dalla Francia alimentano l’interesse e la curiosità delle classi colte, incrementando la lettura delle gazzette nei caffè e nei salotti.
Le prime gazzette politiche italiane
Molte gazzette italiane cominciano a pubblicare resoconti delle attività dell’Assemblea Nazionale francese e documenti rivoluzionari. Tra le più attive vi sono La Gazzetta Universale di Firenze, diretta dall’abate Vincenzo Piombi, e le Notizie del Mondo di Venezia, sotto la direzione di Giuseppe Compagnoni.
Altre testate favorevoli alle idee rivoluzionarie includono la Gazzetta di Bologna e le Notizie Politiche di Roma. Tuttavia, nonostante questa vivacità, mancano dati precisi sulla diffusione, anche se alcune gazzette raggiungono tirature considerevoli per l’epoca.
La stretta censoria e il contrabbando delle idee
Con l’inasprirsi della Rivoluzione francese, le autorità italiane iniziano a reprimere le gazzette. La censura si fa più rigida in Toscana e Lombardia. A Milano, già nel 1790, viene introdotta la possibilità di proibire qualsiasi pubblicazione. I caffè e i gabinetti di lettura diventano luoghi sorvegliati dalla polizia.
Nonostante ciò, il contrabbando di giornali non si arresta. La Gazzetta di Lugano, in lingua italiana, diventa il foglio straniero più diffuso nel Nord Italia, apprezzata per l’equilibrio e la qualità dell’informazione.
I periodici per le donne
Una delle novità più interessanti del periodo è la nascita dei primi giornali femminili. A Firenze, nel 1791, esce il Giornale delle Dame, seguito da riviste come La Donna Galante ed Erudita di Venezia e il Giornale delle Nuove Mode di Francia e d’Inghilterra a Milano.
Il triennio rivoluzionario: esplosione della stampa libera
Con l’arrivo di Napoleone a Milano nel maggio 1796 si apre un triennio di libertà senza precedenti per la stampa. A Milano nascono oltre 40 testate, molte delle quali si occupano di attualità politica, seguono i dibattiti nelle istituzioni e prendono posizione con articoli di fondo.
Nasce un vero giornalismo politico, che supera le vecchie gazzette narrative. I temi centrali sono la libertà di stampa, l’unità d’Italia e il futuro del movimento patriottico. Tra i giornali più importanti troviamo il Giornale degli Amici della Libertà e dell’Uguaglianza, il Termometro Politico della Lombardia, il Monitore Italiano e molti altri.
I protagonisti della stampa rivoluzionaria
Milano diventa la capitale della stampa politica, attirando giornalisti e intellettuali da tutta Italia. Tra i nomi di spicco: Ugo Foscolo, Giuseppe Valeriani, Giovanni Ranza, Pietro Custodi, Giuseppe Lattanzi, Matteo Galdi.
A Napoli, durante la breve esperienza della Repubblica Partenopea, emerge la figura eroica di Eleonora Fonseca Pimentel, direttrice del Monitore Napoletano, che pagherà con la vita la sua fede nei valori democratici.
Il ritorno della repressione
Con la caduta delle repubbliche nel 1799 e il ritorno degli eserciti austro-russi, le gazzette democratiche vengono soppresse. Sopravvivono solo quelle che non si sono compromesse politicamente. Il ritorno di Napoleone nel 1800 segna l’inizio di una nuova fase, più autoritaria. Anche se abolita formalmente, la censura resta efficace.
Il giornalismo sotto Napoleone
Durante il dominio napoleonico, la stampa è strettamente controllata. Un decreto del 1803 impone la censura preventiva e vieta qualsiasi contenuto che possa offendere religione, morale pubblica o autorità politiche. Nel 1806, Napoleone istituisce un “Ufficio della Libertà di Stampa”, ma si tratta solo di un cambiamento di nome.
Il giornalismo si adatta: nascono pubblicazioni ufficiali come il Giornale Italiano, diretto da Vincenzo Cuoco, con l’obiettivo di formare uno spirito nazionale. Le tirature sono modeste ma stabili: tra le 2.000 e le 3.600 copie. Altro giornale importante è il Corriere Milanese.
Il giornalismo letterario e femminile prende piede
Con l’aumento dei controlli, si sviluppano i giornali letterari. A Milano, appaiono firme come Silvio Pellico e Pietro Borsieri. Nel 1804, nasce il Corriere delle Dame, fondato da Carolina e Giuseppe Lattanzi. Questo settimanale, rivolto al pubblico femminile, diventa un punto di riferimento, alternando cronache politiche, moda, racconti e consigli.
Un’eredità che resiste
Dal 1789 al 1814, l’Italia attraversa una profonda trasformazione del giornalismo. La figura del compilatore unico lascia il posto a una redazione più articolata, con direttori, redattori e collaboratori. Le innovazioni tecniche – come la tipografia a vapore e la fabbricazione continua della carta – aprono nuove strade.
Nonostante i periodi di repressione, l’esperienza della libertà di stampa durante il triennio rivoluzionario lascia un segno indelebile. I giornalisti diventano protagonisti della storia, e la stampa comincia a maturare un ruolo centrale nella costruzione dell’identità nazionale italiana.
📘LIBRI CONSIGLIATI
Storia del giornalismo italiano: dalle gazzette ad internet di Paolo Muriardi