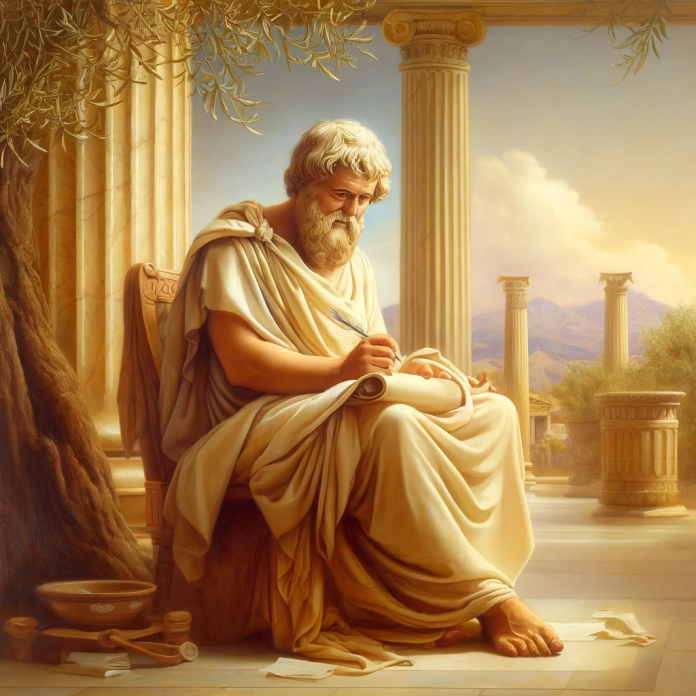Analisi degli scritti di Platone: ordine cronologico, evoluzione stilistica e filosofica, lettere controverse e l’importanza del dialogo nella tradizione filosofica.
Gli scritti di Platone, uno dei più grandi filosofi dell’antichità, sono giunti sino a noi grazie alla tradizione manoscritta che li ha conservati nei secoli. Le sue opere – composte in un arco di circa cinquant’anni, a partire dalla morte di Socrate nel 399 a.C. – si presentano sotto forma di dialoghi. Questi testi sono fondamentali non solo per comprendere il pensiero platonico, ma anche per ricostruire la nascita della filosofia occidentale come ricerca rigorosa del sapere.
La sfida della cronologia degli scritti
Uno dei problemi che ha impegnato maggiormente gli studiosi moderni è stato ricostruire un ordine cronologico plausibile della composizione dei dialoghi platonici. Platone non datò le sue opere, e dunque i ricercatori hanno dovuto basarsi su indagini stilometriche: analisi quantitative della lingua e dello stile impiegato nei testi.
In particolare, l’attenzione si è concentrata su particelle e connettivi logici come infatti, allora, quindi, che Platone utilizzava con frequenze differenti nei vari periodi della sua attività letteraria e filosofica. Studiando statisticamente la presenza di queste particelle nei diversi dialoghi, è stato possibile distinguere testi stilisticamente affini, e quindi verosimilmente scritti in epoche vicine. Al contrario, dialoghi con frequenze molto differenti suggeriscono una distanza temporale significativa nella loro composizione.
Ma come stabilire quale gruppo di dialoghi è più antico e quale più recente? Il punto di riferimento più solido è la notizia, tramandata dalla tradizione antica, secondo cui Le Leggi furono l’ultima opera composta da Platone, pubblicata postuma dal suo discepolo Filippo di Opunte. Assumendo questo dialogo come termine ultimo, gli studiosi hanno potuto costruire una sequenza cronologica relativa degli altri testi.
Certo, questa ricostruzione è attendibile solo nella misura in cui si accetti l’ipotesi che Platone non abbia mai modificato in modo sostanziale i propri scritti a distanza di anni. Qualora invece avesse revisionato alcune opere, come è possibile, l’affidabilità delle analisi stilometriche potrebbe risultare compromessa.
La classificazione in tre fasi
Sulla base di questi criteri, oggi la maggior parte degli studiosi concorda con una ripartizione in tre grandi periodi della produzione platonica:
-
Dialoghi giovanili o socratici (399-388 a.C.):
Questi testi ruotano attorno alla figura di Socrate e ne riproducono il metodo maieutico. Spiccano:
Apologia di Socrate, Critone, Ione, Eutifrone, Carmide, Lachete, Liside, Ippia maggiore, Ippia minore, Protagora. -
Dialoghi della maturità (387-367 a.C.):
Qui si fa più evidente l’elaborazione di un pensiero autonomo, con importanti sviluppi dottrinali, tra cui la teoria delle idee. Ne fanno parte:
Gorgia, Menone, Fedone, Eutidemo, Menesseno, Clitofonte, Repubblica, Cratilo, Simposio, Fedro. -
Dialoghi della vecchiaia (365-347 a.C.):
In quest’ultima fase, Socrate tende a scomparire come protagonista e si passa a una esposizione più sistematica e complessa. I testi principali sono:
Teeteto, Parmenide, Sofista, Politico, Filebo, Timeo, Crizia, Leggi.
Le lettere e gli scritti controversi
Alla produzione dialogica vanno aggiunte tredici lettere attribuite a Platone. Tuttavia, l’autenticità di queste lettere è ampiamente discussa, in particolare della Lettera VII, la più importante, che alcuni ritengono autentica e altri no. Se realmente scritta da Platone, rappresenterebbe una sorta di autobiografia filosofica, in cui l’autore racconta soprattutto le sue esperienze a Siracusa presso la corte di Dionisio.
Nell’antichità, era prassi comune attribuire scritti a grandi nomi del passato per conferirgli maggiore prestigio – ciò avvenne anche con Pitagora e Democrito. Non sorprende quindi che diversi testi siano stati falsamente attribuiti a Platone.
Alcuni dialoghi brevi sono oggi ritenuti apocrifi, ovvero non autentici:
Assioco, Definizioni, Del giusto, Della virtù, Perizia, Ipparco, Minosse, Rivali in amore, Teagete, Sisifo.
Anche l’Epinomide, per lungo tempo ritenuta opera di Platone, è oggi attribuita proprio al già citato Filippo di Opunte.
Lo stile del dialogo platonico
Il contributo forse più originale di Platone alla letteratura filosofica è la scelta del dialogo come forma espressiva. Questa struttura consentiva di mimare dal vivo l’attività filosofica di Socrate nel confronto con i suoi interlocutori. A differenza dei trattati sistematici, il dialogo platonico riproduce il movimento stesso del pensiero nella ricerca della verità.
Platone si serve di due principali tipologie dialogiche:
-
Dialogo drammatico, in cui i personaggi parlano direttamente, come in una scena teatrale.
-
Dialogo narrato o indiretto, in cui spesso è lo stesso Socrate a riferire una conversazione avvenuta in passato.
Nei primi dialoghi, il metodo socratico è ben visibile nell’alternanza serrata di domande e risposte, con l’obiettivo di mettere in crisi le convinzioni dell’interlocutore. Nei dialoghi più tardi, invece, Socrate cede il ruolo di protagonista ad altri personaggi (come l’“Straniero di Elea” o Timeo), e le esposizioni diventano più continue, articolate e sistematiche.
Questa evoluzione riflette il cambiamento nella filosofia di Platone: da un’indagine dialogica e aperta a una costruzione teorica più solida e argomentata, che affronta temi come la cosmologia, la legge, l’anima e la struttura dello Stato.
Gli scritti di Platone non sono solo monumenti della filosofia, ma anche testimonianze letterarie di straordinaria ricchezza. La loro analisi rivela un pensiero in continua evoluzione, capace di reinventarsi pur rimanendo fedele alla vocazione originaria: la ricerca della verità. Ancora oggi, leggere Platone significa entrare in un dialogo che non è mai davvero finito.
🔗 Esplora di più su Platone:
- Cos’è l’Idea del Bene secondo Platone
- La giustizia secondo Platone
- La teoria delle Idee
- La Repubblica di Platone: guida completa tra giustizia, miti e filosofia politica
- Guida Completa a Platone: concetti, miti e opere