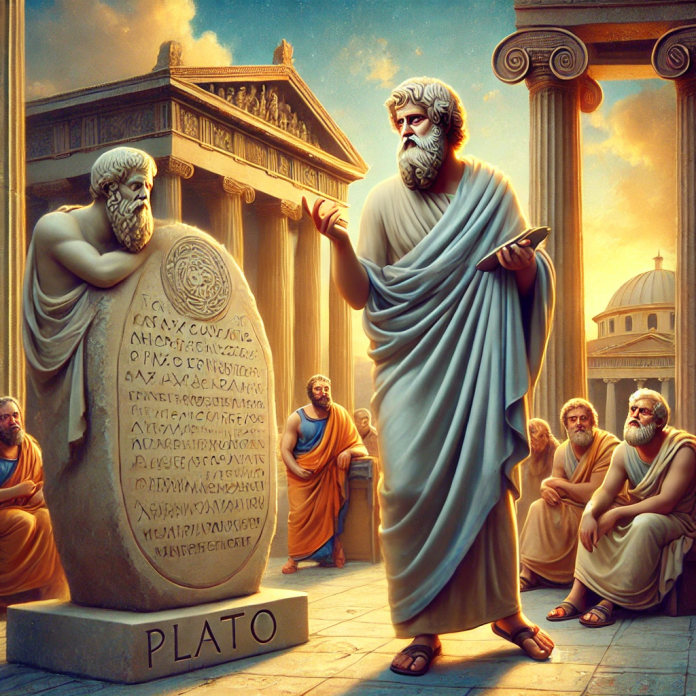Scopri il rapporto tra oralità e scrittura nel pensiero di Platone: una riflessione profonda sulla trasmissione del sapere tra dialogo filosofico e critica alla scrittura.
La cultura greca, dall’epoca omerica fino al V secolo a.C., si fondava prevalentemente sull’oralità, un sistema basato sulla memoria e sulla trasmissione orale del sapere. L’introduzione della scrittura alfabetica, avvenuta nell’VIII secolo a.C., segna l’inizio di una lenta trasformazione culturale che modificherà in modo irreversibile il pensiero occidentale. I primi testi messi per iscritto furono quelli di Omero, probabilmente tra il 700 e il 650 a.C., ma la scrittura in quell’epoca non sostituiva ancora l’oralità: piuttosto, fungeva da supporto a essa.
Nel IV secolo a.C., al tempo di Platone, questo processo di trasformazione era ormai avanzato, ma non ancora del tutto concluso. La cultura orale e il pensiero fondato sulla memoria continuavano a essere dominanti, mentre la scrittura si stava affermando sempre più come strumento di conservazione e diffusione del sapere. Platone si trovò dunque a vivere un’epoca di rivoluzione intellettuale, in cui l’equilibrio tra oralità e scrittura stava mutando radicalmente.
La posizione ambivalente di Platone sulla scrittura
Platone mostra un atteggiamento contraddittorio nei confronti della scrittura. Da un lato, abbandona la cultura oralità poetico-mimetica, basata sulla ripetizione e sull’identificazione emotiva con i poeti, dall’altro difende l’oralità come metodo privilegiato per la trasmissione della vera conoscenza.
È celebre la sua critica alla scrittura, espressa in particolare nel Fedro e nella Settima Lettera. Egli la considera un mezzo inferiore di comunicazione, un semplice gioco rispetto alla serietà della dialettica orale. Tuttavia, Platone è stato anche uno dei più grandi scrittori della storia e ha affidato il suo pensiero a una vasta produzione letteraria, contraddicendo in parte la sua stessa critica.
La sua opposizione alla scrittura non riguarda l’atto di scrivere in sé, ma piuttosto il rischio che essa possa cristallizzare il pensiero e impedire il dialogo, che è invece l’essenza della filosofia. Secondo Platone, la scrittura è statica e non può interagire con il lettore, mentre il dialogo orale permette un confronto dinamico e critico.
La critica alla cultura poetico-mimetica
L’attacco di Platone non si rivolge solo alla scrittura, ma anche alla tradizione poetica orale che fino ad allora aveva svolto un ruolo educativo centrale nella cultura greca. In particolare, nella Repubblica, Platone mette sotto accusa la tradizione ellenica e il sistema educativo basato sui poeti, primo fra tutti Omero.
Secondo Platone, i poeti non trasmettono la verità, ma solo opinioni (doxa). Essi non conoscono realmente ciò di cui parlano e si limitano a creare imitazioni delle imitazioni:
- Le idee sono la vera realtà.
- Le cose materiali sono imitazioni delle idee.
- Le opere dei poeti e degli artisti sono imitazioni delle cose materiali, quindi sono una copia della copia e si allontanano dalla verità.
Platone vuole sostituire questa cultura poetico-mimetica con un nuovo sistema educativo, basato sulla filosofia e sulla ricerca della verità assoluta (epistéme), invece che sulla semplice opinione (doxa).
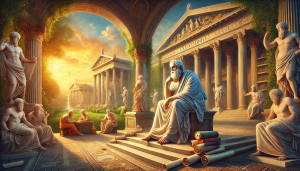
Scrittura, oralità e dialettica: il confronto nel Fedro
Nel Fedro, Platone esprime la sua critica attraverso il mito di Theuth, il dio egizio inventore della scrittura. Secondo il mito, Theuth presenta la scrittura al faraone Thamus, sostenendo che renderà gli uomini più saggi e migliorerà la loro memoria. Tuttavia, Thamus risponde che la scrittura, invece di rafforzare la memoria, la indebolisce, poiché le persone si affideranno ai testi scritti anziché esercitare la propria mente.
In questo dialogo, Platone sottolinea due problemi principali della scrittura:
- La scrittura è statica: non può rispondere alle domande né adattarsi alle esigenze del lettore, a differenza di un maestro che può spiegare e approfondire i concetti in base all’interlocutore.
- La scrittura può essere fraintesa: un testo scritto può essere interpretato in modi diversi, senza che l’autore possa intervenire per chiarire il significato.
Per questo motivo, Platone ritiene che il vero filosofo non debba affidare le cose più importanti ai testi scritti, ma debba comunicarle attraverso l’oralità dialettica, cioè attraverso il dialogo e il confronto diretto.
Platone distingue due tipi di linguaggio nei suoi scritti:
- Un linguaggio chiaro, destinato alla maggior parte dei lettori, per comunicare i concetti più accessibili.
- Un linguaggio allusivo, che lascia intendere concetti più profondi destinati solo ai suoi discepoli, i quali possono comprenderli attraverso il dialogo.
Questa distinzione evidenzia il suo tentativo di mantenere una parte della conoscenza esclusivamente nell’ambito orale e dialettico.
L’oralità dialettica come alternativa alla scrittura
Se Platone critica la scrittura, non significa che abbracci completamente l’oralità. Anzi, egli distingue tra due forme di oralità:
- L’oralità poetico-mimetica, basata sull’imitazione e sulla tradizione epica, che considera fuorviante e inadatta alla ricerca della verità.
- L’oralità dialettica, fondata sul confronto critico e sul dialogo, che rappresenta il vero metodo filosofico.
Platone vede nella dialettica orale lo strumento migliore per trasmettere il sapere, perché permette una trasformazione attiva del pensiero e un confronto diretto tra maestro e discepolo.
La sua critica alla scrittura non è dunque un rifiuto assoluto, ma un’avvertenza sui suoi limiti. Non è sufficiente saper scrivere, ma bisogna sapere quando è opportuno scrivere e quando no. La scrittura è utile solo come promemoria per coloro che già conoscono la verità, ma non può sostituire il vero insegnamento, che avviene attraverso la dialettica orale.
Platone tra oralità e scrittura
Un punto fondamentale se si vuole leggere Platone e capirlo bene, come ci spiega Giovanni Reale nella prefazione del Platone di Thomas A. Szleazak, è che egli non ha scritto tutto quello che ha pensato e ha disseminato tutti i suoi scritti di una serie di rimandi e di omissioni che hanno ben precise finalità.
Platone si trova a un crocevia storico, in un’epoca di transizione tra oralità e scrittura. La sua opera riflette questa trasformazione culturale: da un lato, critica la scrittura per i suoi limiti; dall’altro, la utilizza come strumento per trasmettere il suo pensiero.
Tuttavia, il suo vero obiettivo non è né la difesa dell’oralità né la condanna della scrittura, ma la ricerca del metodo più efficace per giungere alla verità. In questo senso, Platone considera la dialettica orale superiore alla scrittura, perché permette il dialogo, il confronto critico e la crescita intellettuale.
Il suo contributo è stato determinante nel passaggio dalla cultura orale a quella scritta, dimostrando come la filosofia possa trasformare non solo il pensiero, ma anche il modo in cui esso viene trasmesso e insegnato.
🔗 Esplora di più su Platone:
- Cos’è l’Idea del Bene secondo Platone
- La giustizia secondo Platone
- Dove parla Platone dell’anima? Un viaggio nei dialoghi platonici
- La teoria delle Idee
- La Repubblica di Platone: guida completa tra giustizia, miti e filosofia politica
- Guida Completa a Platone: concetti, miti e opere
📚 Libri consigliati su Platone: