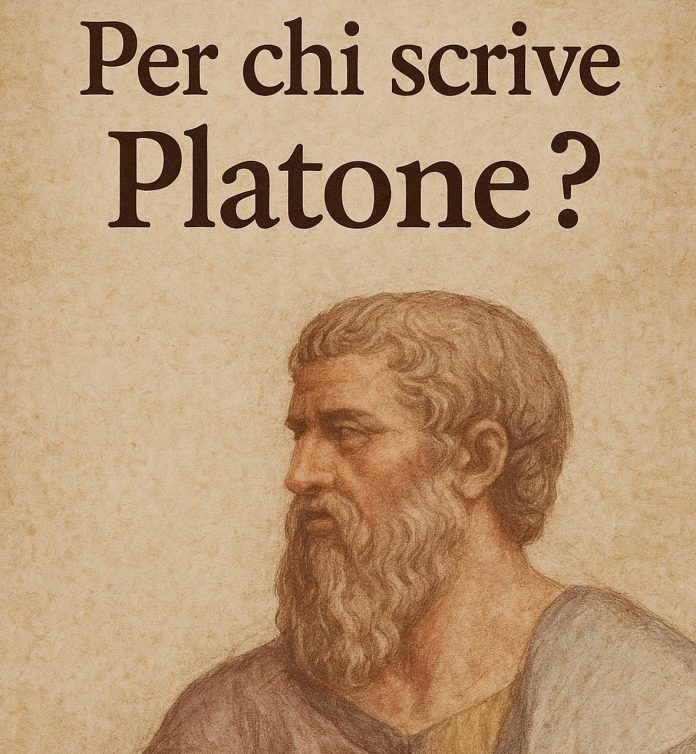Analisi approfondita del pubblico dei dialoghi platonici: destinatari, livelli di comprensione, funzione protrettica, e teoria dell’esoterismo tra scrittura e oralità secondo Platone.
Il problema del pubblico platonico
È una domanda fondamentale. Comprendere il pubblico a cui Platone si rivolge è cruciale per valutare con consapevolezza l’elenco delle caratteristiche delle sue opere. Tuttavia, non intendiamo affrontare la questione soltanto seguendo l’indirizzo della cosiddetta “estetica della ricezione”. Le osservazioni condotte finora ci hanno già mostrato come Platone fosse ben consapevole del fatto che i contenuti filosofici possano essere ricevuti in modi diversi, a seconda dei lettori. Forse fu proprio questa consapevolezza a spingerlo a scegliere con cura il proprio pubblico?
Non esiste da parte di Platone alcuna dichiarazione esplicita e vincolante in questo senso – né potevamo aspettarcela, considerando la sua predilezione per la drammatizzazione costante della materia filosofica. Dobbiamo quindi affidarci alla deduzione basata sul contenuto e sul tono dei dialoghi. Ma qui il quadro non è affatto uniforme.
I diversi livelli di destinatari nei dialoghi
All’estremo più accessibile troviamo il Critone, breve e toccante dialogo in cui le Leggi parlano a Socrate, convincendolo a rimanere fedele alla città. Questo testo, con la sua carenza di argomentazioni tecniche, sembra rivolgersi a lettori non specialisti, ma seriamente orientati verso la morale e la lealtà civica.
All’estremo opposto si colloca il Timeo, che espone non solo una profonda dottrina dei principi naturali, ma nella seconda parte presenta contenuti specialistici tratti da diverse discipline scientifiche. È evidente che un’opera simile richieda una preparazione sistematica e possa essere recepita adeguatamente solo da lettori esperti o da chi possiede almeno una solida formazione culturale.
Anche il Parmenide, nella sua seconda parte, è un esempio di scrittura esigente: pur mantenendo la forma del dialogo, rinuncia a eleganza e vivacità per concentrarsi rigorosamente sulla logica dei concetti astratti. Lo stesso vale per altri dialoghi tardi come il Teeteto, il Sofista, il Politico e il Filebo, nei quali gli interlocutori sono giovani filosofi, e l’argomentazione assume un tono scolastico, quasi da manuale di esercitazione accademica.
Da qui alcuni studiosi deducono che Platone abbia scritto i suoi dialoghi primariamente per i suoi allievi dell’Accademia, affinché fossero strumenti di esercizio e approfondimento. In virtù della loro educazione preliminare, questi studenti sarebbero stati in grado di affrontare enigmi e aporie, colmare i vuoti argomentativi e trarre da ogni testo ciò che è sottinteso.
Tuttavia, l’idea che esistano tre distinti gruppi di destinatari – dilettanti, esperti e allievi dell’Accademia – è difficile da sostenere in modo rigido. I nuovi membri dell’Accademia, all’inizio, erano culturalmente simili ai dilettanti; al tempo stesso, allievi dotati potevano rapidamente diventare esperti grazie all’intensità degli studi. Nessun dialogo, inoltre, è così elementare da essere inutile a chi possiede già una formazione filosofica, né così oscuro da non offrire nulla a un principiante.
Il problema della comunicazione filosofica
Nel Fedro, Platone stesso afferma che gli scritti migliori hanno valore come ausilio alla memoria di chi già sa. Il filosofo scrive “per gioco”, per procurarsi un mezzo di ricordo in età avanzata. Ma chi sono coloro che seguono le orme di Platone? Possiamo davvero limitarli agli allievi dell’Accademia?
Supponiamo pure che molti dialoghi fossero pensati come materiale per l’insegnamento; ciò non implica che non fossero destinati anche a un pubblico colto più vasto. Platone sapeva bene che, una volta pubblicato, un libro poteva circolare liberamente e raggiungere ogni tipo di lettore. Se avesse voluto evitarlo, avrebbe preso misure per impedirne la diffusione.
Al contrario, sappiamo dagli scritti di Isocrate che i dialoghi platonici erano letti anche al di fuori dell’Accademia. Opere come il Fedone, il Simposio, il Fedro e il Menone sono scritte con una raffinatezza stilistica che le rende fruibili a un pubblico letterario colto. Lo stesso vale per dialoghi come l’Apologia, il Gorgia e la Repubblica, i cui contenuti politici non sarebbero spiegabili come rivolti solo a un gruppo ristretto.
Platone quindi, pur scrivendo spesso per lettori “interni” alla filosofia, non esclude nessuno. La sua opera ha una funzione protrettica: invita alla filosofia anche chi ne è ancora lontano. Scriveva consapevolmente per tutti – o meglio, per chiunque fosse in grado di seguirlo.
Ma possiamo dire che Platone volesse raggiungere pubblici diversi con lo stesso testo, magari con un messaggio diverso per ciascuno? Possedeva forse una tecnica letteraria che gli permetteva di comunicare in modo differenziato?
Due forme di esoterismo
Secondo Ludwig Wittgenstein, se un libro è scritto per pochi, lo si capisce dal fatto che saranno pochi a comprenderlo. Un testo efficace si protegge da solo: pone un “lucchetto” visibile solo a chi ne possiede la chiave. Il resto può solo ammirare l’esterno. Alcuni studiosi hanno applicato questa visione a Platone, ipotizzando che i suoi dialoghi siano dotati di un “lucchetto ermeneutico”: chi lo riconosce e lo apre, accede al significato più profondo.
Questa è la cosiddetta moderna teoria del dialogo platonico, avviata da Schleiermacher, secondo la quale il dialogo scritto è una forma letteraria attiva, capace di scegliere da sé i propri lettori, rispondendo in modo diverso a seconda della loro capacità interpretativa.
Tuttavia, Platone nel Fedro critica proprio la scrittura: essa, dice, ripete sempre se stessa, non può difendersi né scegliere i propri lettori. Solo il filosofare orale è realmente vivo. Quindi, anche se la teoria moderna ritiene che il dialogo scritto possa supplire a questa mancanza, Platone non sembra condividere questa opinione.
A ben vedere, quindi, le due grandi interpretazioni del pubblico platonico non sono “esoterica” contro “non esoterica”, ma due forme diverse di esoterismo:
Esoterismo immanente al dialogo (ermeneutico): il messaggio è presente nei testi, ma accessibile solo a chi ha gli strumenti giusti per comprenderlo.
Esoterismo storico: Platone ha una dottrina profonda che non viene scritta, ma solo insegnata oralmente, come suggerisce Aristotele nella Metafisica.
Per distinguere tra queste due visioni, è necessario considerare la concezione platonica della scrittura, i limiti che egli stesso le attribuisce, e anche il valore morale che attribuisce al lettore.
Infatti, non basta l’intelligenza per accedere alla filosofia. Nel Carmide, Socrate può esercitare il suo “incantesimo” solo se l’interlocutore è disposto a riceverlo. Nel Gorgia, Callicle viene escluso non per mancanza di acume, ma per disposizione morale. Nella Repubblica, Platone sottolinea che la vera natura filosofica richiede virtù etiche oltre che intellettuali.
Dunque, qualsiasi teoria della comunicazione filosofica platonica deve tenere conto non solo delle capacità intellettuali, ma anche della disposizione morale del lettore.
✅ Comprensione generale
-
Qual è la domanda centrale a cui il testo cerca di rispondere?
-
Quali sono gli estremi della scala dei destinatari a cui Platone potrebbe rivolgersi, secondo il testo?
-
Quali dialoghi sono considerati accessibili a un pubblico più ampio?
-
Che ruolo hanno gli allievi dell’Accademia nella ricezione dei dialoghi platonici?
Analisi e interpretazione
-
In che modo il contenuto e il tono dei dialoghi possono aiutare a comprendere il pubblico a cui Platone si rivolge?
-
Perché si afferma che Platone scrivesse “consapevolmente per tutti”?
-
Qual è la funzione protrettica dei dialoghi platonici?
-
Che cosa intende Wittgenstein con la metafora del “lucchetto”, e come viene applicata a Platone?
Confronto tra teorie
-
Quali sono le due principali teorie moderne sull’intenzione comunicativa dei dialoghi platonici?
-
In cosa consiste la differenza tra esoterismo ermeneutico ed esoterismo storico?
-
Qual è la posizione di Schleiermacher sulla forma dialogica platonica?
-
Come si contrappone a quella di studiosi come Konrad Gaiser e Hans Krämer?
Critica e approfondimento
-
Perché Platone, secondo il Fedro, critica la scrittura come mezzo filosofico?
-
Qual è il ruolo della disposizione morale, oltre che intellettuale, nella comprensione dei dialoghi platonici?
-
Perché non è possibile dividere nettamente i destinatari dei dialoghi in gruppi distinti?
Domande aperte per elaborazione personale
-
-
Qual è, secondo te, il vantaggio di usare il dialogo come forma filosofica?
-
Ritieni possibile che un testo possa “scegliere” da solo i propri lettori? Argomenta.
-
Pensi che la filosofia dovrebbe essere accessibile a tutti o riservata a chi ha una preparazione adeguata?
-
In che modo oggi possiamo applicare il concetto di “lucchetto ermeneutico” a testi complessi?
-
Cosa rivela questo dibattito sulla scrittura e l’oralità riguardo al nostro modo moderno di trasmettere sapere?
-
🔗 Esplora di più su Platone:
- Cos’è l’Idea del Bene secondo Platone
- La giustizia secondo Platone
- La teoria delle Idee
- La Repubblica di Platone: guida completa tra giustizia, miti e filosofia politica
- Guida Completa a Platone: concetti, miti e opere