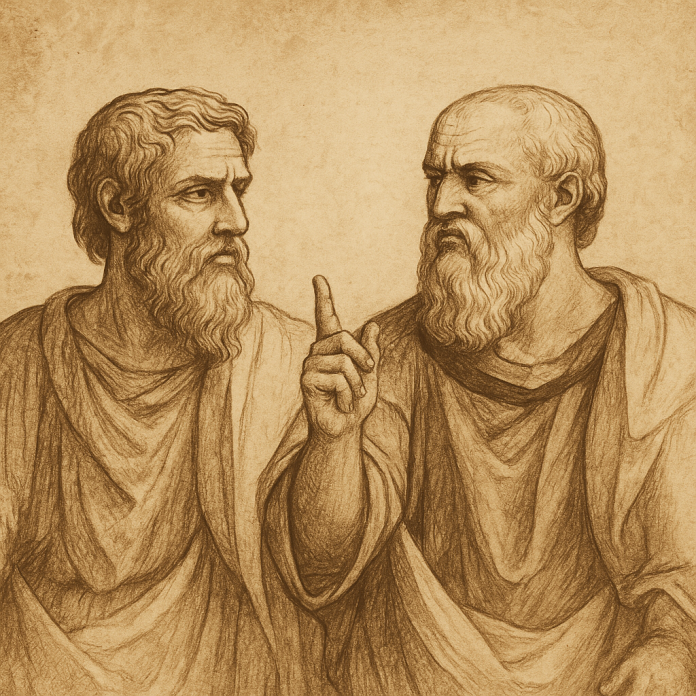Un’analisi del confronto tra la teoria protezionista dello Stato di Licofrone e l’opposizione totalitaria di Platone secondo Karl Popper: origini del pensiero contrattualistico, giustizia, e il ruolo del potere tra egualitarismo e autoritarismo.
Licofrone e la nascita della teoria protezionista dello Stato
Secondo Karl Popper, Licofrone fu uno dei primi pensatori a formulare una concezione dello Stato radicalmente diversa da quella dominante nella Grecia classica. In un’epoca in cui la filosofia politica tendeva a fondare l’organizzazione dello Stato sulla virtù o sull’ordine naturale, Licofrone avanzò una visione “contrattualistica” e “protezionista” del potere politico. La legge, per Licofrone, non era uno strumento per rendere i cittadini virtuosi, ma un patto tra individui, volto a garantire giustizia reciproca. Lo Stato diventava così un’associazione cooperativa per prevenire il crimine e per proteggere i cittadini dagli atti d’ingiustizia.
Aristotele riferisce questa posizione con disprezzo, sottolineando come essa si limitasse a considerare solo lo scopo minimo dello Stato: la sicurezza. Tuttavia, proprio questo limite era per Popper un punto di forza. Licofrone formulava una teoria che si sottraeva alle debolezze e alle contraddizioni della tradizionale teoria storicistica del contratto sociale. In effetti, come rileva lo studioso Ernest Barker, anche le critiche rivolte alla teoria del contratto sociale non riescono a intaccare la posizione di Licofrone, che si distingue per chiarezza e realismo.
L’idea fondamentale del protezionismo politico, nella lettura di Popper, è la protezione del debole dal potere arbitrario del forte. Una richiesta non soltanto avanzata dai deboli, ma spesso anche sostenuta da coloro che, pur forti, vedevano nel diritto una garanzia universale di stabilità e convivenza.
L’opposizione di Platone: tra retorica e potere
Popper sostiene che Platone, pur conoscendo bene la teoria di Licofrone (di cui era contemporaneo, anche se più giovane), la reinterpretò e la respinse. Nei suoi dialoghi principali – il Gorgia e la Repubblica – Platone mise in scena personaggi che illustrano concezioni simili a quella protezionista, ma sempre in forma indiretta, tramite interlocutori con cui Socrate o lui stesso finiscono per polemizzare.
Nel Gorgia, è Callicle a rappresentare la teoria dell’origine della giustizia come frutto di un patto tra i deboli per difendersi dalla forza dei potenti. Callicle però la rigetta, e così facendo si pone in contrasto con Socrate. Platone, in questa fase, sembra difendere la posizione protezionista, lasciando intendere che lo Stato possa e debba limitarsi alla protezione dei cittadini. Nella Repubblica, invece, è Glaucone – influenzato da Trasimaco – a esporre la teoria egoistica e contrattualistica dell’origine dello Stato. Questa viene però smontata da Socrate, che assume il ruolo di eroe morale, difensore della giustizia come virtù dell’anima e ordine gerarchico della società.
Popper osserva una contraddizione: Platone, che nel Gorgia sembra simpatizzare per il protezionismo, nella Repubblica lo rigetta come nichilistico ed egoistico. Eppure, secondo Popper, Platone non riuscì mai davvero a confutare la base morale del protezionismo. L’intera sua argomentazione si riduceva a contestarne la presunta origine egoistica. Non fu la reticenza a impedirgli di presentare obiezioni più valide, ma la semplice mancanza di argomenti.
Il protezionismo come espressione dell’umanesimo egualitario
Nella lettura di Popper, la teoria di Licofrone rappresenta la forma più antica e pura di un’istanza egualitaria e umanitaria nata nell’età di Pericle. Il protezionismo politico nasce come difesa dei diritti individuali e della giustizia in senso universale. Ma questa concezione fu trasmessa alle generazioni successive in modo distorto, sotto forma di storicismo (come nella teoria dell’origine dello Stato da un contratto sociale) o di essenzialismo (che pretende individuare una “vera natura” dello Stato come convenzione), o ancora come teoria dell’egoismo.
Popper vede nel protezionismo non una dottrina di debolezza, ma una proposta di civiltà: il tentativo di regolare la convivenza attraverso il diritto e la cooperazione, e non mediante la superiorità morale o politica di una classe o di un’élite. È una teoria della limitazione del potere e del riconoscimento della dignità individuale, in netto contrasto con le concezioni autoritarie.
Platone e la restaurazione del tribalismo
Secondo Popper, la filosofia politica di Platone, dalla Repubblica in poi, rappresenta un vero tentativo di restaurazione del tribalismo. Tutta la sua teoria della giustizia si fonda sul rifiuto dell’egualitarismo e dell’individualismo che stavano emergendo nella cultura ateniese del V secolo. Platone reagisce rilanciando un ideale aristocratico e gerarchico: la giustizia consiste nel mantenere ogni classe al proprio posto, e i “migliori” – i filosofi – devono governare per il bene dello Stato.
La funzione dello Stato non è più quella di proteggere i diritti, ma di realizzare un ordine ideale che legittima i privilegi di una élite. In questa visione, i sentimenti umani sono riassorbiti e riorientati per servire il progetto totalitario. L’umanità, la compassione, la giustizia distributiva vengono subordinati a un disegno autoritario in cui lo Stato ha fine a sé stesso, e le classi dirigenti si autolegittimano in nome della “virtù”.
In conclusione, secondo Popper, Platone sacrificò le istanze umanitarie al servizio del totalitarismo, mentre la teoria protezionista di Licofrone resta come testimonianza di un progetto politico autenticamente liberale e moderno.
🔗 Esplora di più su Platone:
- Cos’è l’Idea del Bene secondo Platone
- La Repubblica di Platone: guida completa tra giustizia, miti e filosofia politica
- Guida Completa a Platone: concetti, miti e opere